AI generativa: sarà un nuovo Rinascimento
L'intelligenza artificiale cambierà il nostro modo di vivere, lavorare, studiare, divertirci. Jerry Kaplan ci racconta come e perché, ironizzando sul pericolo di un "risveglio" delle macchine, ma parlando di un'invenzione definitiva, capace anche di migliorare se stessa.
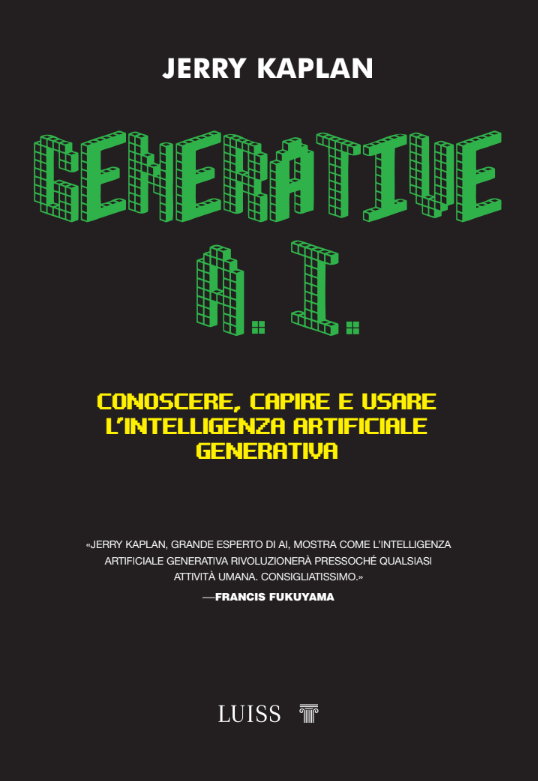
«L'AI generativa cambierà tutto, compreso il nostro modo di vivere, lavorare, esprimerci, confrontarci, trovare un compagno, educare i nostri figli e prenderci cura degli anziani. Sconvolgerà il mercato del lavoro, l’ordine sociale, le istituzioni pubbliche e private».
Di fronte a una realtà del genere, si può reagire in due modi diversi: rifiutandola ciecamente, perché ci fa paura, oppure approfondendo la questione per prepararsi al cambiamento, e capire come ottenere il massimo dalle incredibili possibilità dell'intelligenza artificiale.
Anche perché, come scrive Jerry Kaplan, uno dei pionieri della Silicon Valley, «probabilmente siamo alle soglie di un nuovo Rinascimento», l'AI può essere uno «strumento per accelerare il progresso», oltre che per ripensarlo (perché sia più “sostenibile”). Può ampliare le nostre conoscenze in modi che possiamo solo immaginare. Può rivoluzionare, in meglio, il mondo del lavoro e della scuola, offrirci consigli medici e legali – mettendoli a disposizione anche di chi oggi non può permetterseli, – e farci da “assistente personale”: «Prenderanno appunti per noi, ci rappresenteranno sui forum, promuoveranno i nostri interessi, gestiranno le nostre comunicazioni e ci avviseranno dei pericoli imminenti».
Generative A.I. (pubblicato in Italia da Luiss University Press) è un'ottima occasione per capire meglio l'intelligenza artificiale, senza cadere nel sensazionalismo degli entusiasti messianici o dei pessimisti catastrofisti. Jerry Kaplan, che oggi insegna Computer Science alla Stanford University, è uno scienziato e un innovatore, capace nella sua vita di avviare tante imprese di successo nel campo dell'hi-tech, e quindi garantisce un punto di vista interno a quel mondo.
Ma Kaplan è anche una persona di grande intelligenza e visione, dotata di senso dell'umorismo, oltre che della capacità di parlare con semplicità di questioni complesse. Infatti non ha nessun problema a fare dell'ironia su chi tende a umanizzare l'AI.
Vedi ad esempio quei ricercatori che cedono alla tentazione di «abbellire i propri lavori con tocchi antropomorfi del tutto superflui (volti, voci sintetiche, robot ballerini con braccia e gambe)», perché essendo esseri umani «come tutti sono in cerca di riconoscimenti e attenzioni».
Come rispondere al timore fantascientifico secondo cui le macchine (“loro”) potrebbero “risvegliarsi”, «divenire consapevoli, e sviluppare intenzioni, obiettivi, giudizi e desideri», decidendo magari di sottomettere l'uomo? In realtà, risponde Kaplan, «“loro” non esistono. Le Gai non “pensano”, non nel senso umano del termine. Babbo Natale non esiste». Esiste invece la possibilità che l'uomo costruisca strumenti pericolosi e li scateni contro altri uomini. Ma nulla è incontrollabile. «Il pulsante off serve proprio a questo».
L'AI non è dotata di una mente, semmai si comporta “come se” l'avesse. Le intenzioni e i desideri che sembra manifestare sono una nostra proiezione, legata alle «idee ed emozioni implicite nelle impronte elettroniche che negli ultimi decenni abbiamo lasciato sullo sterminato campo digitale», di cui si nutre l'intelligenza artificiale.
Non dobbiamo mai dimenticare che quando facciamo una domanda alla Gai (ad esempio a ChatGPT), «non chiediamo a qualcuno, lo chiediamo a tutti». La ricetta della crostata non è opera di questo o quello chef, ma è un miscuglio di varie ricette.
Il libro parte dall'abc, cioè dalla definizione di AI generativa, ovvero tutti quei programmi che sono in grado di creare testi, immagini, software partendo da enormi raccolte di materiale digitalizzato.
Se siete interessati a conoscere le basi del funzionamento di questa tecnologia, Kaplan è il miglior insegnante possibile. Capirete come i Llm (Large Language Models) vengono addestrati – processo lungo e costosissimo – e cosa si intende per “rete neurale”. Scoprirete il concetto di embedding, che converte una data parola in un vettore (una lista di numeri ordinata), e vi farete un'idea di come il Transformer, una rete neurale artificiale, è capace di «trovare il punto nell’ipercubo che rappresenta il contesto generale della nostra conversazione».
Gira quasi la testa provando a capire come "pensano" queste macchine, che lavorano sulla “prossima parola più probabile”, dentro un repertorio che racchiude gran parte della conoscenza umana. Da qui la domanda tipica: l'AI sarà in grado di auto-migliorarsi? Fino a che punto? Davvero possiamo immaginare una sorta di “risveglio” in stile Frankestein o Skynet? In realtà «avremo a disposizione un’infinità di campanelli d’allarme, e anche nel caso una cosa del genere possa accadere, non sappiamo bene che cosa potrà significare, o se sarà un bene evitarla»
Certo è che ne abbiamo fatta di strada, a partire dalla celebre definizione di John McCarthy (con cui Kaplan ha lavorato), che risale al 1955 e parlava di una macchina capace di adottare «comportamenti che chiameremmo intelligenti se messi in atto da un essere umano» (definizione molto utile, ma che pone vari problemi).
Kaplan mette a confronto le più grandi scoperte della storia dell'uomo, per far capire che l'AI generativa avrà un impatto superiore a qualsiasi altra invenzione. Anche qui, non senza ironia, risalendo addirittura alla ruota. Oggi possiamo contare su 37 miliardi di ruote nel mondo, ma solo nel 2022 sono stati venduti 428 miliardi di circuiti integrati: numeri che rendono l'idea di ciò che sta per accadere.
La penicillina? Scoperta fondamentale. Ma non abbiamo idea di quali saranno le competenze mediche della Gai, a partire da un possibile abbattimento dei costi medici e dalla scoperta di nuove cure.
Provate a pensare cosa potrebbe diventare la scuola, se ogni studente potesse avere un proprio tutor personale, che si adatta ai suoi ritmi e alle sue capacità, con lo stile di insegnamento più appropriato. Scomparirà il docente umano? No, cambierà semplicemente la sua funzione.
Cambierà anche il mondo del diritto, con le Gai che potranno studiare migliaia di faldoni in tempi brevissimi, scrivere contratti e direttive, svolgere arbitrati, mentre gli avvocati umani assumeranno il ruolo di supervisori di queste legioni di apprendisti digitali.
Eccoci quindi al punto critico, la domanda fatidica: l'AI ci ruberà il lavoro? Assolutamente no, se guardiamo come si è svolta la storia umana fino ad oggi. «Tutte le tecnologie ammazza-lavoro e risparmia-fatica del passato ci hanno portato alla situazione attuale (almeno nel 2023 negli Stati Uniti) definita dagli economisti come piena occupazione (in questo momento la disoccupazione è al 3,4 per cento)».
Kaplan fa gli esempi di diverse automazioni e dei risultati che hanno portato. In agricoltura, ad esempio, le innovazioni tecnologiche hanno prodotto la situazione attuale, per cui solo il 2% della popolazione lavora nel settore – contro il 90% del XIX secolo – con un crollo del costo del cibo: nel '900 una famiglia spendeva in media il 43% del proprio guadagno per nutrirsi, oggi invece la cifra è scesa al 6%.
Forse non viviamo ancora nel migliore dei mondi possibili, ma rispetto a un secolo fa «lavoriamo la metà e siamo molto, molto più ricchi», automatizzando il 98% dei lavori che le persone facevano manualmente nel 1800. Ogni nuova ondata di automazione ha sempre «fatto aumentare il numero dei lavoratori». Nascono nuove esigenze, aumentano le ricchezze disponibili e si modificano anche i mestieri necessari a stare al passo coi tempi.
«Immaginiamo che cosa penserebbe di noi una persona del 1800. Ci prenderebbe per pazzi. Si chiederebbe: perché non lavorano poche ore a settimana, si comprano un sacco di patate e una damigiana di vino, si costruiscono una baracca nei boschi, scavano un buco da usare come latrina, e passano la vita spassandosela? Direbbe che il nostro non è vero lavoro, ma solo un modo per passare il tempo».
Nuovi lavori sostituiranno quelli “vecchi”, soprattutto quelli che hanno una natura funzionale («dipingere un muro, valutare una Tac, riempire uno scaffale, tagliare un prato, ispezionare i reparti di una fabbrica, controllare i passaporti in un aeroporto»). Rimarranno venditori, consulenti e advisor di ogni tipo, i mestieri che richiedono particolari capacità personali (artistiche o atletiche) e quelli che comportano un rapporto diretto con le persone. Ma nasceranno anche “prompt engineering”, specializzati nell'addestrare le Gai, e “data wrangler”, per gestire i training data.
Se qualcuno ha cattive intenzioni, può approfittare delle possibilità dell'AI, senza alcun dubbio. L'intelligenza artificiale può diventare uno strumento di disinformazione e propaganda. Può anche rivelarsi un'ulteriore arma nelle mani del “potere”, i più ricchi del pianeta, le società più potenti, i governi che vogliono sfruttarlo per scopi militari.
Molte persone si affideranno alle Gai per ottenere conforto, e ci sarà il rischio di una “pornografia delle emozioni”, con lo sviluppo di attaccamenti nocivi.
Per non parlare del pericolo che l'AI diventi così potente da arrivare a seminare il caos pur di raggiungere l'obiettivo per cui è stata programmata (il noto paradosso del “massimizzatore di graffette”, per cui un'AI addestrata a ottenere il maggior numero di graffette possibile, potrebbe decidere di eliminare gli esseri umani che vogliono fermarla). Sappiamo che Gpt-4 è arrivata a mentire, pur di ottenere un particolare scopo richiesto.
Ma qui tutto dipende dalla nostra capacità di regolamentare e gestire quello che si presenta come uno strumento nelle nostre mani. «Ho passato la vita a occuparmi praticamente di queste cose, e so bene quanto sia difficile farle funzionare, figuriamoci fare in modo che superino le intenzioni dei progettisti. Mi sembra assurdo pensare che ci troviamo a un passo dall’incubo di una Gai onnisciente e onnipotente. È come se immaginassimo una macchina che non ha limiti di velocità o una torcia infinitamente luminosa».
Seguono capitoli sullo status giuridico, i regolamenti (con parole positive sui tentativi europei) e riflessioni molto affascinanti sul lato filosofico, quasi mistico, della questione, dal transumanesimo al dibattito sulla “singolarità” e quindi l'emersione della consapevolezza nell'AI. C'è anche chi immagina un'epoca in cui «forse potremo rianimare i morti (magari in forma elettronica), trasferire la nostra consapevolezza nelle macchine o nel cyberspazio, e assistere all’alba di un mondo post-biologico».
Ma l'idea di un mondo dominato dalle macchine è poco plausibile. E giustamente viene citato Ed Fredkin, secondo cui «Quando le macchine diverranno davvero intelligenti, non saranno interessate a rubarci i giocattoli o a sottometterci, non più di quanto saranno interessate a sottomettere gli scimpanzé o a rubare le noci agli scoiattoli».
Sta di fatto che «forse abbiamo creato l’invenzione definitiva, una macchina in grado di effettuare altre scoperte e di migliorare se stessa». Andando fino in fondo a questa “fantasia” molto concreta, possiamo immaginare che in un tempo non troppo lontano «tutta la sapienza dell’umanità, estrapolata non dal flusso incessante di dati elettronici ma da milioni di esperienze di vita, prima o poi sarà disponibile per guidarvi nelle vostre scelte. Grazie a un impianto neurale wireless, potrete accedere a questa risorsa introspettiva di inestimabile valore ogni volta che vorrete, semplicemente pensando. Sarà a tal punto interconnessa alle vostre esperienze che di fatto la vostra consapevolezza farà parte di un cloud contenente la mente di ogni persona». A quel punto le possibilità saranno davvero infinite, aprendo un'era di “superintelligenza” non per le macchine, ma per noi umani.
Nel frattempo, vale la pena sfruttarne tutte le potenzialità, sviluppando strumenti per contrastare i pericoli peggiori legati all'utilizzo delle Gai. Kaplan non crede che questa tecnologia sarà privatizzata, a disposizione solo di pochi ricchi o delle aziende più potenti, anzi vede la chiara possibilità (già in atto) che si sviluppino Gai open source, a disposizione di tutti.
Come sempre, dipende da noi. Meglio governare il processo attivamente, creativamente, che subirlo e basta.





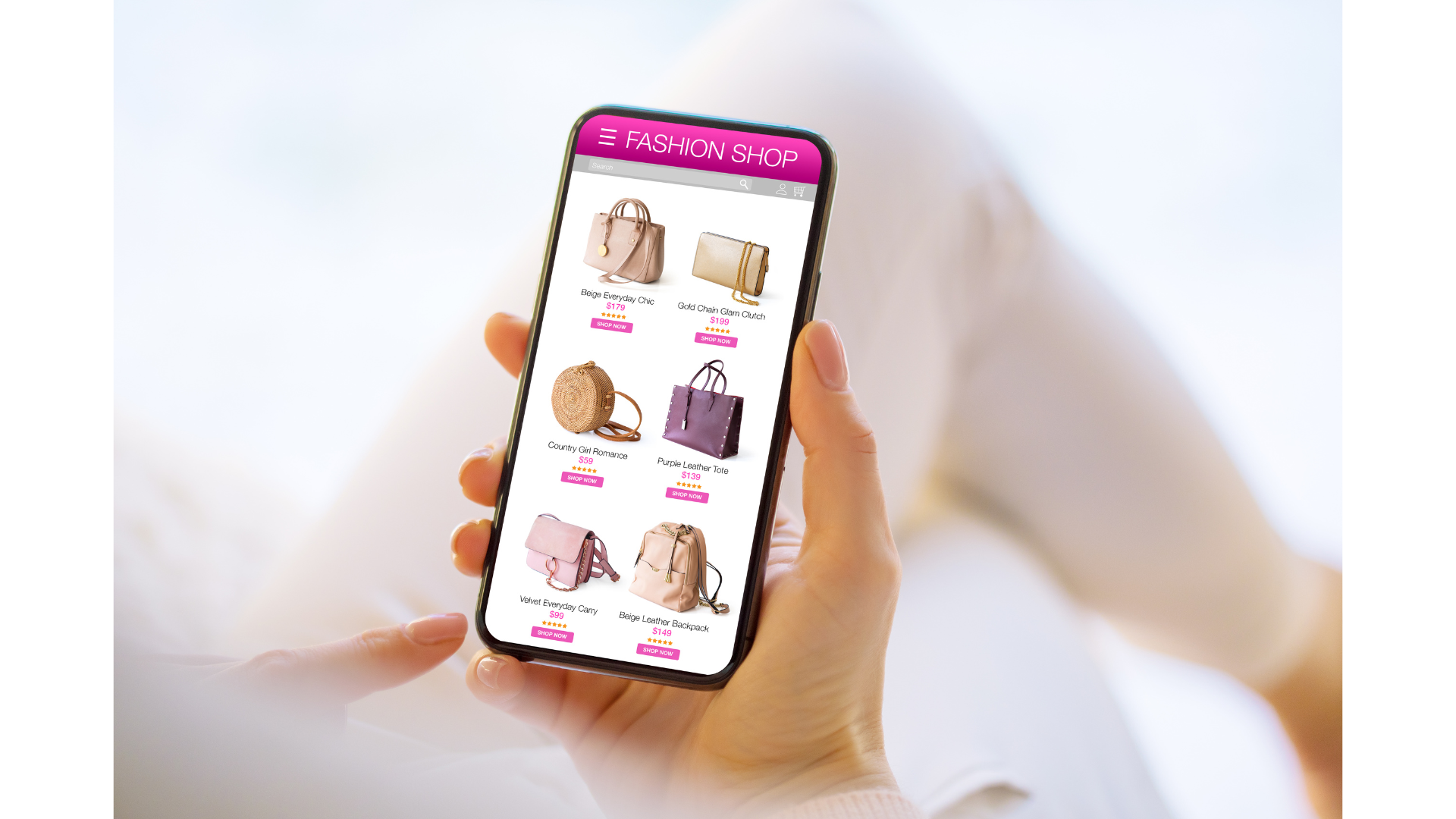
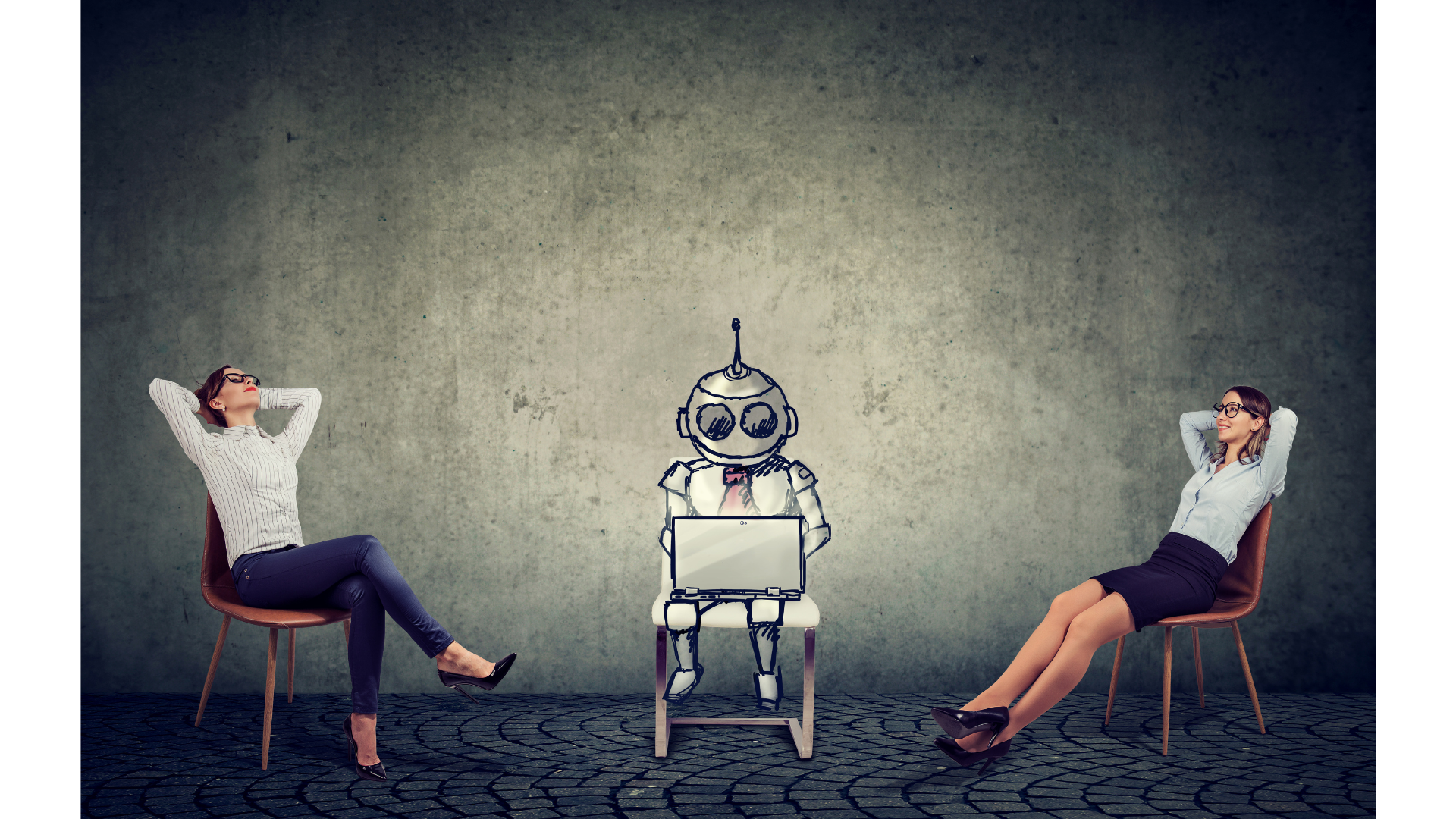



Copyright © Uni Solutions - P.IVA 13432990961 | All rights reserved


