Layout del blog
L'AI ci ruberà il lavoro? No, lo farà crescere
18 marzo 2025
Le riflessioni di Jerry Kaplan contro il luogo comune sull'intelligenza artificiale ammazza-lavoro. La storia dimostra che le innovazioni tecnologiche (alla lunga) producono ricchezza e benessere.

L'AI ci ruberà il lavoro? Molti la pensano così. Il buon senso comune tende a fare l'equazione: “più robot al lavoro = meno esseri umani”. Ma, come spiega Jerry Kaplan, «ogni volta che una tecnologia rivoluzionaria
arriva al grande pubblico, non mancano le geremiadi per i poveri lavoratori che perderanno il posto». Peccato che la storia del mondo dimostri esattamente il contrario. Lo scienziato americano, pioniere della Silicon Valley, che questi temi li conosce bene, nel suo Generative A.I.
(pubblicato in Italia da Luiss University Press), ci ricorda che «tutte le tecnologie ammazza-lavoro e risparmia-fatica del passato ci hanno portato a una situazione definita dagli economisti come piena occupazione», negli Usa e in Occidente in generale.
Prendiamo ad esempio l'agricoltura automatizzata. Nel 1800 lavorava in questo settore il 90% della popolazione americana (oggi il 2%) e ogni famiglia spendeva il 43% del proprio reddito per il cibo (oggi il 5%, compresi i ristoranti). E che dire delle fabbriche, dei traporti, del mondo della comunicazione? Vorrà pur dire qualcosa se, calcolato secondo l'inflazione, il PIL della famiglia media americana è passato dai 1000 dollari del 1800 ai 60mila dollari del 2023. Dati di questo genere si posso ritrovare in Italia e nei paesi europei.
L'economia si trasforma, così come la modalità di produzione dei beni (materiali e immateriali). Ci sono sempre stati momenti di cambiamento, assestamenti più o meno difficili, con una ridistribuzione della forza lavoro
verso nuovi settori produttivi.
Oggi automatizziamo il 98% dei lavori
che i nostri avi facevano due secoli fa. Gran parte del nostro reddito odierno viene speso per “beni superflui”, per il piacere, la qualità della vita, il divertimento, la cultura, a differenza di quell'epoca in cui a trent'anni eri vecchio (sì, il progresso ha portato anche la longevità) e tutto il reddito veniva destinato alla sussistenza.
L'intelligenza artificiale, dicono, porterà all'automazione di 300 milioni di posti di lavoro. La cifra appare catastrofica a leggerla così, in astratto. Ma non significa che 300 milioni di persone rimarranno senza occupazione. Semplicemente, in questo momento non siamo in grado di immaginare che mestiere faranno. D'altra parte quanti sanno che il 57% dei lavori che svolgevamo nel 1960 oggi non esiste più?
L'AI, anzi la Gai (l'intelligenza artificiale generativa), dovrebbe portare a un aumento della produttività dell'1,5%
nei prossimi decenni. Quindi, sì, può darsi che spariscano, o cambino drasticamente, mestieri pratici
come «dipingere un muro, valutare una Tac, riempire uno scaffale, tagliare un prato, ispezionare i reparti di una fabbrica, controllare i passaporti in un aeroporto»
(risolvendo però anche molti problemi, intrinsecamente umani, in vari campi, a partire da quello medico).
Mentre è improbabile che vengano toccati mestieri «che richiedono la capacità di interagire faccia a faccia, di capire un’altra persona ed empatizzare
con lei, o in generale l’espressione autentica di emozioni umane. Pensiamo a venditori, consulenti e advisor di ogni sorta», ma anche «chi è dotato di particolari capacità personali, come i musicisti, i performer e gli atleti», il luxury e l'assistenza personale, «infermieri, guide turistiche, baristi, dog sitter, sarti, chef, istruttori di yoga e massaggiatori».
Ma soprattutto arriveranno nuovi mestieri, dal “prompt engineering”
ai “data wrangles”, dai software engineer
agli addetti al monitoraggio delle AI
o i «consulenti di Reinforcement Learning from Human Feedback (Rlhf, apprendimento supplementare tramite il feedback umano)».
Tutto dipenderà dalla nostra capacità di ripensare la formazione professionale, soprattutto di chi rischierà il lavoro. Formazione (e aggiornamento) che non sarà più solo una questione di welfare, di investimento sociale dello Stato, ma un settore su cui anche i privati dovranno spendersi, per sostenere il processo di cambiamento. «Dobbiamo smetterla di credere che la formazione professionale sia un salvagente lanciato dal governo, e cominciare a considerarla per quello che è davvero: un investimento legittimo con un valido scopo economico».

27 marzo 2025
Unite l'empatia del medico (il buon medico) e la super-intelligenza dell'AI , e avrete un nuovo modo di intendere la prevenzione e la cura. Da una parte le capacità relazionali, creative, intuitive di un essere umano, dall'altra le possibilità dell'intelligenza artificiale, che può analizzare e confrontare milioni di dati, non si stanca mai, non si lascia condizionare da stress ed emozioni forti. Tra i settori che l'AI è destinata a rivoluzionare in positivo, c'è sicuramente la medicina . Anzi, la rivoluzione è già cominciata, grazie ai progressi dell' intelligenza artificiale generativa . L'AI sta rapidamente trasformando il panorama medico, offrendo strumenti innovativi che migliorano diagnosi e trattamenti. Questa tecnologia, che fino a qualche anno fa era relegata ai laboratori di ricerca, è ora una realtà concreta in molti ospedali e cliniche. Diagnosi più accurate e tempestive Uno dei campi in cui l'AI sta facendo la differenza è la diagnostica per immagini . Alcuni ospedali hanno integrato programmi di intelligenza artificiale nel loro reparto di radiodiagnostica, migliorando la precisione e la rapidità nell'interpretazione di radiografie e altre immagini mediche. Sono sistemi che assistono i radiologi nell' identificare patologie come fratture, polmoniti e versamenti pleurici, ottimizzando i tempi di risposta, soprattutto nei reparti di emergenza. Monitoraggio remoto dei pazienti L'AI sta rivoluzionando anche il monitoraggio domiciliare dei pazienti in condizioni croniche. Ad esempio, il Servizio di Cardiologia dell'ospedale Virgen de la Arrixaca ha implementato un assistente medico virtuale basato su AI chiamato "Lola". Questo sistema effettua chiamate autonome ai pazienti con insufficienza cardiaca, raccoglie informazioni sul loro stato di salute e le analizza per individuare segnali di peggioramento. Il personale sanitario può così intervenire tempestivamente, migliorando l'aderenza al trattamento e prevenendo complicanze. Prevenzione delle emergenze mediche Un'altra applicazione significativa dell'AI è nella prevenzione delle morti improvvise in ospedale . Il sistema "CHARTWatch" , sviluppato in Canada, utilizza l'intelligenza artificiale per monitorare i pazienti in pronto soccorso e identificare quelli a rischio elevato di deterioramento. Durante un periodo di prova, questo sistema ha contribuito a ridurre del 25% le morti inattese , dimostrando il potenziale dell'AI nel migliorare gli esiti clinici. Personalizzazione dei trattamenti L'intelligenza artificiale sta aprendo la strada a trattamenti sempre più personalizzati. La biofisica Natalia Trayanova , ad esempio, ha sviluppato "gemelli digitali" del cuore umano utilizzando dati medici e modelli computazionali. Questi modelli virtuali permettono di simulare e prevedere l'efficacia di diversi trattamenti per aritmie e altre malattie cardiovascolari, consentendo ai medici di scegliere l'approccio terapeutico più adatto a ogni paziente. Sfide ed etica nell'adozione dell'AI Nonostante i progressi, però, l'integrazione dell'AI in medicina presenta sfide significative, sia dal punto di vista tecnico che da quello etico. È essenziale garantire la sicurezza e la privacy dei dati dei pazienti, nonché affrontare questioni morali legate all' uso di algoritmi decisionali . Inoltre, è fondamentale che i professionisti sanitari mantengano un ruolo centrale nel processo decisionale, utilizzando l'AI come strumento di supporto piuttosto che come sostituto. Umano + AI = il super-dottore del futuro Per quanto straordinari siano questi progressi, è fondamentale ribadirlo: l’intelligenza artificiale non sostituirà mai il medico umano . La diagnosi non è solo questione di numeri e algoritmi: è empatia, ascolto, interpretazione del contesto. È saper guardare il paziente negli occhi e capire quello che non dice. La macchina può analizzare dati in pochi secondi, ma non potrà mai leggere le sfumature dell’animo umano. E proprio qui nasce la vera opportunità: la collaborazione tra uomo e tecnologia . Immagina un medico che ha a disposizione, in tempo reale, l’analisi di migliaia di casi clinici simili, suggerimenti basati su letteratura aggiornata, previsioni sull’andamento della malattia. E che poi decide cosa fare, come farlo, e soprattutto come dirlo al paziente. È questo il futuro della medicina: un “super-dottore” che unisce il meglio dell’intelligenza umana e artificiale, per una sanità più efficiente, precisa e profondamente umana .

11 marzo 2025
La sostenibilità rende . Lo dicono i numeri e le esperienze sul campo. Anzi, la sostenibilità rende doppiamente, sia alle aziende che all'ambiente (sociale e naturale) in cui operano. Non si tratta di essere “politicamente corretti”, non è una questione solamente ideale, ma anche pratica ed economica. Bisogna fare di necessità virtù. Sempre più, negli ultimi anni, la sostenibilità è diventata un elemento chiave per il successo e la competitività delle aziende . Per le PMI italiane , investire in pratiche sostenibili non è solo un obbligo imposto dalle nuove normative europee, ma anche un'opportunità per crescere, migliorare l’efficienza e accedere a nuovi mercati. La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) , introdotta dall'Unione Europea, ha ampliato il perimetro della rendicontazione ESG (ambientale, sociale e di governance), estendendo indirettamente i suoi effetti anche sulle PMI, in particolare quelle inserite in filiere produttive con aziende di grandi dimensioni. Il contesto normativo: la CSRD e l’impatto sulle PMI L’Unione Europea ha introdotto la CSRD per rafforzare la trasparenza e la rendicontazione delle imprese in materia di sostenibilità. Se inizialmente la normativa si applicava solo alle grandi aziende già soggette alla Non-Financial Reporting Directive (NFRD) , ora il perimetro si è allargato. La normativa coinvolge progressivamente le imprese con oltre 250 dipendenti e, indirettamente, anche le PMI che fanno parte della loro catena di fornitura . Con l'approvazione del Pacchetto Omnibus (febbraio 2025), gli obblighi di rendicontazione diretta sono stati limitati alle grandi imprese con più di 1.000 dipendenti e un fatturato superiore a 50 milioni di euro, ma l’influenza della CSRD continuerà a pesare anche sulle PMI fornitrici. La Commissione Europea, consapevole delle difficoltà che le PMI possono incontrare nel fornire dati ESG dettagliati, ha sviluppato il VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs) , uno standard che consente alle piccole e medie imprese di comunicare in modo strutturato e semplificato le proprie performance di sostenibilità. Questo strumento facilita la transizione ESG per le piccole e medie imprese , permettendo loro di rimanere competitive e di rispondere alle richieste dei “grandi clienti”. I benefici della sostenibilità per le PMI Adottare strategie di sostenibilità non deve essere visto solo come un obbligo normativo, ma come un’opportunità di crescita . Integrare i criteri ESG nel proprio modello di business consente alle PMI di ottenere numerosi vantaggi: 1. Accesso a finanziamenti e agevolazioni fiscali - Le banche e gli investitori sono sempre più attenti ai criteri ESG e stanno sviluppando strumenti finanziari specifici per sostenere le imprese sostenibili. Ci sono grandi banche che hanno deciso di introdurre finanziamenti con condizioni agevolate per le PMI che si impegnano a migliorare il proprio impatto ambientale e sociale. Inoltre, diverse agevolazioni fiscali e incentivi, sia a livello nazionale che europeo, vengono messi a disposizione per le aziende che investono in pratiche sostenibili. 2. Riduzione dei costi operativi - L’adozione di strategie di sostenibilità può portare a una maggiore efficienza nell’uso delle risorse e a una riduzione dei costi. Ad esempio, investire in soluzioni per l’efficienza energetica e il risparmio idrico può diminuire le spese a lungo termine. Secondo uno studio di GreenItaly, le PMI italiane che hanno investito in tecnologie green hanno ridotto i loro costi energetici del 20-30%. 3. Maggiore attrattività per clienti e investitori - Le imprese che dimostrano un forte impegno nella sostenibilità sono percepite più positivamente dai clienti, dagli stakeholder e dagli investitori. Secondo un rapporto dell’ISTAT, il 59,5% delle imprese manifatturiere italiane ha adottato strategie di sostenibilità nel 2022, con il 50,3% che si è concentrato sulla tutela ambientale. Tuttavia, il 36,1% delle piccole imprese non ha ancora intrapreso iniziative concrete in questo ambito, evidenziando un potenziale di crescita significativo per chi decide di investire in ESG. 4. Aumento della competitività e della resilienza aziendale - Essere sostenibili significa anche essere più preparati alle sfide future. Le imprese che adottano strategie ESG tendono a essere più resilienti nei periodi di crisi, a migliorare le relazioni con fornitori e clienti e a ridurre il rischio di controversie legali o sanzioni dovute a mancata conformità normativa. 5. Conformità agli standard della filiera produttiva - Molte grandi imprese stanno introducendo criteri ESG nella selezione dei propri fornitori. Le PMI che non si adeguano rischiano di essere escluse dalle filiere di fornitura di aziende leader, compromettendo importanti opportunità di business. Investire in sostenibilità diventa quindi un requisito indispensabile per rimanere all’interno dei network di produzione più avanzati e per garantirsi contratti di fornitura a lungo termine. Come le PMI possono integrare la sostenibilità Per implementare efficacemente strategie ESG, le PMI possono adottare un approccio graduale, partendo da alcuni passi fondamentali: Effettuare un'analisi di sostenibilità: valutare il proprio impatto ambientale, sociale e di governance per individuare le aree di miglioramento. Adottare il VSME: utilizzare il modello semplificato di rendicontazione ESG per PMI per rispondere in modo efficace alle richieste di trasparenza. Investire in innovazione e digitalizzazione: tecnologie smart e digitali possono ridurre l’impronta ambientale e aumentare l’efficienza operativa. Formare il personale: sensibilizzare i dipendenti sui temi della sostenibilità per migliorare il coinvolgimento e l’efficacia delle strategie ESG. Creare partnership strategiche: collaborare con aziende del settore, enti pubblici e organizzazioni per accedere a risorse e supporto finanziario. Per le PMI italiane, investire in sostenibilità non è più un'opzione, ma una necessità per restare competitive e garantire il successo a lungo termine. L'integrazione dei criteri ESG nel business non solo permette di rispondere agli obblighi normativi, ma offre vantaggi concreti in termini di efficienza, attrattività per gli investitori, accesso al credito e consolidamento della propria posizione sul mercato. L'adozione di strategie sostenibili oggi significa prepararsi al futuro, migliorando la resilienza aziendale e creando valore per l’intero ecosistema economico.
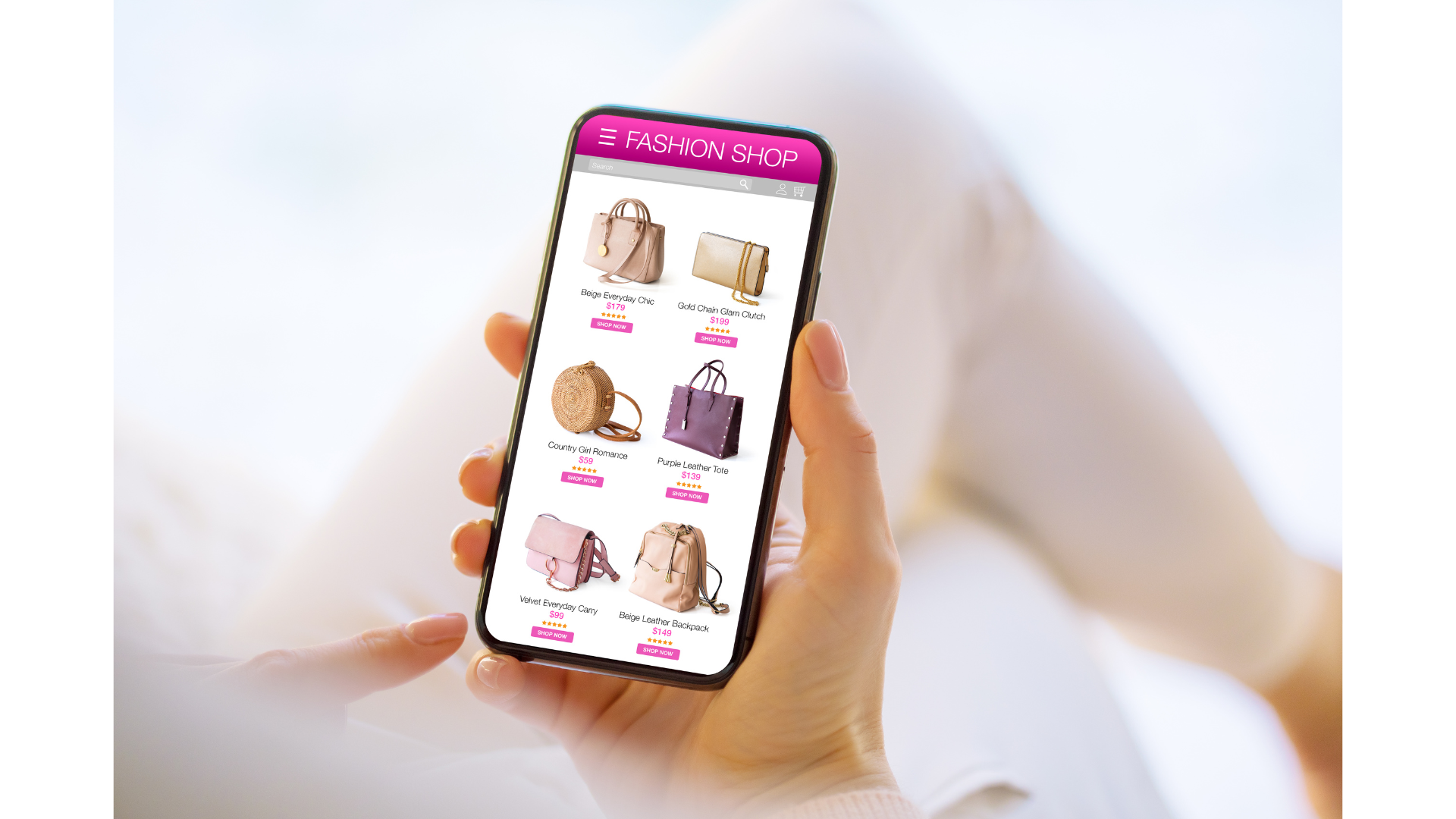
28 febbraio 2025
I numeri del 2024 confermano il profondo cambiamento in atto nel marketing digitale . Il protagonista di questa rivoluzione? Ovviamente l’ intelligenza artificiale . Di cui si parla molto in termini astratti, ideologici, e pochissimo per le sue applicazioni pratiche, che di fatto stanno già trasformando il modo in cui le aziende si presentano online, alla ricerca di nuovi clienti. Una rivoluzione in atto anche in Italia, dove le abitudini digitali dei consumatori si stanno allineando a quelle dell’Europa più evoluta, crescendo in modo perentorio. Come è cresciuta anche l’attitudine a investire sul web . Crescita del mercato digitale e degli investimenti pubblicitari La spesa per la pubblicità digitale in Italia ha superato i 5,5 miliardi di euro nel 2024, con una forte propensione verso canali innovativi come il mobile advertising, che rappresenta il 65% del mercato, l'Advanced/Connected TV e il Retail Media. Una tendenza che riflette l'adattamento delle aziende alle nuove modalità di consumo dei contenuti, sempre più spostata verso il digitale. Adozione dell'intelligenza artificiale nel marketing L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando le strategie di marketing, permettendo alle aziende di offrire esperienze altamente personalizzate e di effettuare analisi predittive per anticipare le preferenze dei consumatori. Anche in Italia, l'AI è diventata un elemento chiave per la personalizzazione dell'esperienza utente, consentendo alle imprese di adattare in tempo reale le proprie offerte alle esigenze specifiche dei clienti. Utilizzo del web e dei social media in Italia Nel 2024, quasi 43 milioni di italiani, pari al 73% della popolazione , risultavano attivi sui social media. Nonostante una leggera diminuzione del 2,5% rispetto all'anno precedente, il tempo medio trascorso sui social è aumentato. TikTok domina con una media di 32 ore e 12 minuti al mese per utente, seguito da YouTube con 18 ore e 15 minuti e Facebook con 16 ore e 37 minuti. Crescita dell'e-commerce in Italia Gli acquisti online in Italia hanno superato i 58,8 miliardi di euro , registrando un incremento del 6% rispetto al 2023. I settori più dinamici, da questo punto di vista, sono l’arredamento/home living, la cosmetica, gli integratori e il settore farmaceutico, tutti in crescita del 12%, seguiti dagli alimentari e i prodotti per la casa, con un aumento del 7%. La penetrazione dell' e-commerce sul totale del retail ha raggiunto il 13%, evidenziando una crescente fiducia dei consumatori italiani nel commercio digitale. Sfide e opportunità per le PMI italiane Le piccole e medie imprese (PMI) italiane si trovano di fronte alla necessità di innovare per rimanere competitive. L'adozione di tecnologie emergenti come l'AI e l' Automated Capable Intelligence (ACI) offre l'opportunità di automatizzare processi e migliorare l'interazione con i clienti. Tuttavia questo richiede investimenti in tecnologia e formazione specialistica, oltre a una perfetta integrazione con le strategie aziendali esistenti. Dal punto di vista del marketing digitale, non sembrano esserci alternative, ormai, all’adozione di strumenti che consentano di monitorare il mercato online in tempo reale. Non basta più lavorare sulla targetizzazione della pubblicità (digitale), occorre lavorare perché il brand sia presente nel momento in cui viene cercato il prodotto in questione. Conclusione: nuove opportunità Il 2024 ha segnato un punto di svolta per il marketing digitale, anche in Italia. L'integrazione dell'intelligenza artificiale nelle strategie di marketing, unita alla crescente digitalizzazione dei consumatori, sta creando nuove opportunità per le aziende , prima inimmaginabili. Le imprese che sapranno abbracciare queste tecnologie e adattarsi alle nuove dinamiche del mercato saranno in grado di costruire anche relazioni più solide e durature con i propri clienti, garantendo una crescita sostenibile nel tempo.
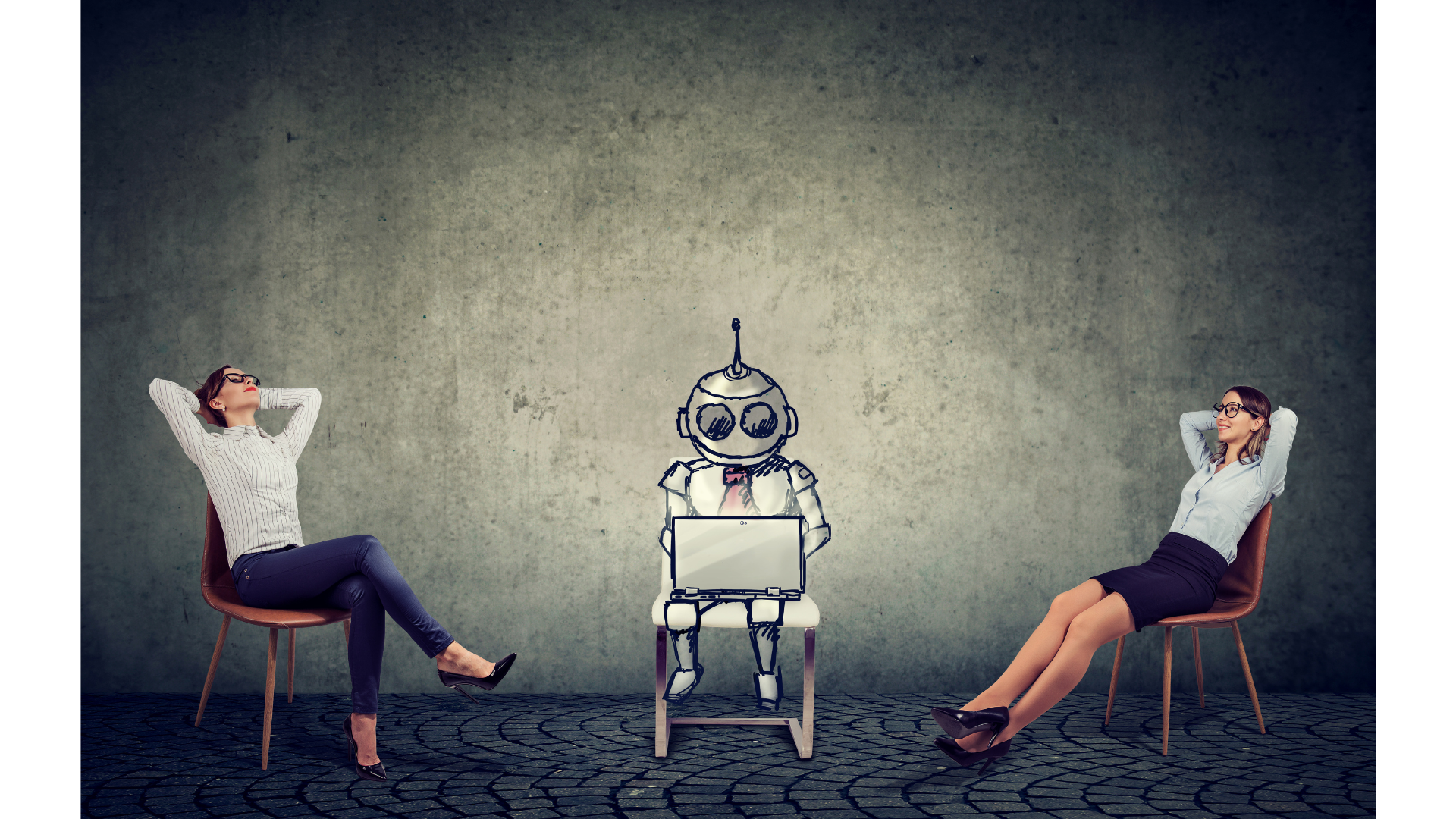
10 febbraio 2025
Tutti d'accordo sull'intelligenza artificiale in azienda: semplifica i processi gestionali, migliora la comunicazione, accelera la crescita. In futuro sarà sempre più indispensabile anche sul fronte del marketing, in un mondo in cui la pubblicità tradizionale (di massa) è sempre meno efficace, perché l'utente-cliente è sempre più indipendente nelle sue ricerche, e l'AI può aiutarci a intercettare le sue richieste. Ma i dati dicono che le PMI italiane faticano ad aggiornarsi. Impegnate a inseguire i problemi quotidiani, faticano ad avere una visione orientata al futuro. Infatti solo il 7% delle piccole imprese, e il 15% delle medie, ha avviato progetti di AI, a dimostrazione delle difficoltà che ancora persistono in termini di investimenti e competenze tecnologiche. Un dato impressionante, soprattutto se paragonato al 59% delle grandi aziende. Questo è uno degli elementi emersi i l 6 febbraio al Politecnico di Milano, nel convegno "Artificial Intelligence, e questo è solo l'inizio", organizzato dagli Osservatori Digital Innovation. L'evento ha rappresentato un'importante occasione per fare il punto sulla diffusione e l'impatto dell'intelligenza artificiale in Italia, evidenziando le opportunità e le sfide di un settore in vertiginosa espansione nel mondo. Il mercato risulta in crescita anche in Italia. Secondo i dati presentati dall'Osservatorio Artificial Intelligence, nel 2024 il settore ha registrato un incremento del 58%, raggiungendo un valore complessivo di 1,2 miliardi di euro, a conferma di un trend positivo che sta trasformando il panorama tecnologico ed economico del Paese. Una crescita dovuta soprattutto alle grandi imprese, tra le quali l'81% ha almeno valutato progetti basati sull'AI e il 59% ha già avviato iniziative concrete. Ovviamente si è parlato soprattutto di intelligenza artificiale generativa (Generative AI), tecnologia che sta rivoluzionando diversi settori, offrendo soluzioni avanzate per la creazione di contenuti testuali, immagini e modelli predittivi. Il 65% delle grandi aziende italiane impegnate in questo settore sta già sperimentando soluzioni di Generative AI, soprattutto per migliorare l'efficienza dei processi interni e sviluppare nuovi servizi. Tuttavia, non mancano le criticità. Tra le preoccupazioni principali ci sono gli aspetti etici e normativi legati all'utilizzo di questa tecnologia. Solo il 28% delle aziende ha adottato misure concrete per conformarsi all'AI Act dell'Unione Europea, mentre il 52% ammette di non avere una chiara comprensione del quadro normativo. Questo evidenzia la necessità di una maggiore sensibilizzazione e di linee guida più chiare per garantire uno sviluppo etico e sostenibile dell'AI. Un altro punto chiave affrontato durante il convegno è il rapporto tra intelligenza artificiale e mondo del lavoro. L'adozione di tecnologie AI solleva inevitabilmente interrogativi sul futuro dell'occupazione. Secondo i dati dell'Osservatorio, solo il 17% dei lavoratori italiani che hanno avuto esperienza con strumenti AI valuta molto positivamente il loro impatto. Mentre una parte significativa teme che l'automazione possa ridurre le opportunità lavorative. Ma gli esperti del settore continuano a ripetere che, al di là degli inevitabili assestamenti - caratteristici di ogni periodo di transizione verso un "nuovo paradigma" - la rivoluzione AI porterà alla nascita di nuove professionalità. Così è stato in passato, quando le trasformazioni tecnologiche hanno modificato il mondo del lavoro, ampliando le possibilità di impiego e facendo crescere l'economia, e così accadrà anche in futuro. Il dato positivo è che, nonostante le diffidenze e gli allarmismi diffusi, l'opinione pubblica sull'AI è generalmente positiva: il 59% degli italiani dichiara di avere un'opinione favorevole, riconoscendo il potenziale della tecnologia nel migliorare la qualità della vita e i servizi. Tuttavia, esistono timori, ad esempio legati alla manipolazione delle informazioni e alla diffusione di fake news, un problema che richiede strumenti di regolamentazione adeguati e strategie efficaci di alfabetizzazione digitale. La carenza di competenze è uno degli ostacoli principali alla diffusione dell'intelligenza artificiale in Italia. Le aziende lamentano una difficoltà crescente nel reperire professionisti specializzati in AI, data science e machine learning. Per colmare questo gap, gli esperti intervenuti al convegno hanno sottolineato l'urgenza di investire nella formazione, sia a livello universitario che attraverso programmi di aggiornamento per i lavoratori già attivi. Altro aspetto cruciale: la regolamentazione. Con l'imminente applicazione dell'AI Act europeo, le imprese dovranno adottare misure più stringenti per garantire trasparenza e affidabilità. Il dibattito durante il convegno ha messo in luce la necessità di una collaborazione tra istituzioni, imprese e ricercatori, per sviluppare normative equilibrate. Sembra un'ovvietà, ma non lo è. Da una parte c'è il rischio di un eccesso di burocrazia, dall'altra quello di un 'innovazione che sacrifica la sicurezza e i diritti dei cittadini. Tutti d'accordo, comunque, sul fatto che l'intelligenza artificiale rappresenti una delle sfide più importanti per il futuro dell'Italia. Le opportunità offerte dall'AI sono immense, ma per sfruttarle appieno è necessario affrontare con determinazione le criticità legate alla regolamentazione, alla formazione e all'adozione nelle PMI. Nei prossimi anni, la capacità di integrare l'AI in modo etico ed efficace determinerà il successo dell'Italia in questa rivoluzione tecnologica. Gli esperti intervenuti al convegno hanno sottolineato l'importanza di un approccio collaborativo tra pubblico e privato. Solo così le aziende saranno incoraggiate a intraprendere la strada dell'innovazione.

28 gennaio 2025
La sfida cinese all'AI americana si chiama Deep Seek e sta provocando un terremoto. Lo dicono i numeri, a partire dal sorpasso di ChatGPT negli Usa, come applicazione più scaricata dall'App Store (Apple). E lo dicono i crolli in borsa degli ultimi giorni. Cosa c'è di così straordinario nel chatbot prodotto da una sconosciuta startup, guidata da un giovane “nerd spettinato” (come veniva descritto da qualcuno l'imprenditore Liang Wenfeng?). Essenzialmente il costo, molto contenuto , necessario a realizzarla, così come le risorse tecnologiche modeste da cui sarebbe nato. Il che metterebbe in discussione i progetti e gli investimenti miliardari messi in campo dai giganti del tech. Detto questo, va sottolineato che è impossibile avere certezze su un'applicazione nata sotto l'ombrello della censura cinese . Davvero sono bastati 6 milioni di dollari , e i “vecchi” chip Nvidia H800, per arrivare a Deep Seek-V3 (modello di punto) e al recente R1, così performante nel problem solving e nella capacità di sviluppare ragionamenti avanzati? Per non parlare dei problemi di privacy – come/dove vengono trattati i dati di chi la utilizza? - e i limiti imposti dal governo cinese: a quanto pare ci sono argomenti sensibili (Tienanmen e dintorni) sui quali l'intelligenza artificiale diventa misteriosamente reticente. A spaventare le aziende americane, in realtà, è il fatto che si parla di un prodotto open-source , che sembra mettere in crisi il modello di sviluppo dell'AI occidentale, basata sulla logica del brevetto. Se un modello open-source, che mette il proprio algoritmo a disposizione di tutti, ha le stesse prestazioni di un'applicazione proprietaria, quest'ultima rischia di perdere valore. Dal punto di vista tecnologico, Deep Seek si distingue per un approccio modulare . Mentre ChatGPT-4 di OpenAI è un sistema centralizzato basato su modelli di deep learning sofisticati, addestrati su enormi dataset, il chatbox cinese sfrutta un'architettura che consente a sviluppatori indipendenti di personalizzare e migliorare il modello. Questa flessibilità ha favorito un rapido adattamento alle esigenze degli utenti e un’accelerazione nell’implementazione di nuove funzionalità. Deep Seek sembra avvalersi di un sistema di apprendimento distribuito , che consente aggiornamenti continui attraverso i contributi di una vasta comunità di sviluppatori globali. Questo contrasta con l'approccio più controllato di OpenAI, che richiede processi interni rigorosi per l’aggiornamento e il miglioramento del modello. L’apertura del codice comporta una minore protezione delle innovazioni tecnologiche, rendendo difficile per le aziende statunitensi capitalizzare sui propri investimenti. Questa trasparenza però alimenta anche preoccupazioni relative alla sicurezza , poiché il codice è accessibile non solo agli sviluppatori legittimi ma a potenziali attori malevoli. Negli Stati Uniti, dove l’AI è considerata strategica per la sicurezza nazionale, l’adozione di tecnologie open source come Deep Seek rischia di ridurre il vantaggio competitivo rispetto ad altre nazioni. Ciò alimenta un dibattito acceso sulla necessità di bilanciare trasparenza e controllo nel settore. Ma cosa cambia per noi utenti? Dipende dagli scenari che si stanno aprendo, cioè dagli sviluppi dell'AI open source e le sue possibili applicazioni. Oggi come oggi, ChatGPT-4 sembra essere più affidabile, anche a parità di performance. Entrambe sono in grado di comprendere ed elaborare un linguaggio naturale, di scrivere testi complessi, di generare risposte sofisticare. Ma ChatGPT-4 opera all’interno di un ecosistema regolamentato e monitorato , mentre Deep Seek, pur essendo innovativa, manca di standard universali per garantire sicurezza e conformità. Quanto alle differenze in termini di funzionalità, basta chiedere a ChatGPT, e la risposta sarà sorprendentemente (?) completa e obiettiva. Il chatbot di OpenAI si fa notare per la flessibilità : «È progettato per essere un assistente generale che copre una vasta gamma di argomenti, come linguaggio naturale, analisi, programmazione, scrittura creativa, ricerca e altro. Ideale per spiegazioni dettagliate, brainstorming, e aiuto in compiti complessi. Sviluppato per produrre risposte naturali e accurate, è adatto a intraprendere conversazioni umane» . Deep Seek invece si fa apprezzare per la specializzazione e l'adattabilità : «È uno strumento avanzato che utilizza metodi di ricerca o elaborazione mirata, solitamente legato a specifici domini. È pensato per estrarre dati da grandi volumi di informazioni o eseguire ricerche mirate con alta precisione. Potrebbe essere più efficiente per compiti di ricerca tecnica, pattern recognition, o simulazioni, ma meno "umano" nel tono. Viene spesso usato in ambienti accademici o per problemi specialistici» . Riassumendo: per chi ha bisogno soprattutto di una conversazione fluida e spiegazioni ad ampio spettro, ChatGPT-4 è probabilmente la scelta migliore. Chi invece va alla ricerca di risultati analitici specifici e tecniche avanzate di data mining , potrebbe scoprire che Deep Seek è più adatto allo scopo. Ma siamo solo all'inizio di una sfida che si prospetta ricca di colpi di scena .

17 gennaio 2025
L' AI generativa sta suscitando attese mai viste prima, in tutti i campi. E un flusso di investimenti privati che, secondo alcuni analisti, è il più grande mai generato nella storia. Il che significa che primo o poi questi investimenti andranno monetizzati, ad esempio sul fronte delle applicazioni. Parte da qui la “raccolta annuale di infografiche” degli Osservatori Digital Innovation , una realtà nata all'interno del Politecnico di Milano che da venticinque anni monitora e racconta l'innovazione digitale, facendo incontrare aziende, ricercatori ed esperti. Chi più di loro è consapevole del fatto che ormai i «confini del mondo digitale sono sempre più fuzzy – indefiniti» ? Si moltiplicano i processi di digitalizzazione , in tutti i comparti dell'economia, e le possibilità offerte da questo settore. Tanto che gli argomenti-capitoli presi in considerazione dagli Osservatori, per fotografare il 2024, sono ben quarantasette. Nell'introduzione si parla anche della perdita di competitività delle aziende europee, sottolineando lo scarso sviluppo del reparto tech, e ci si domanda come si caratterizzerà la presidenza Trump sul fronte dell'innovazione. Ma il tema che più ci interessa è quello dell'AI generativa, presentata come “la più grande promessa e la più grande incognita del mondo tech”. A partire da quel 30 novembre 2022 in cui Sam Altman presentò ChatGPT , lanciando la “next big thing”, «l'occasione da non perdere per la crescita futura» . I dubbi e i problemi non mancano, dai fabbisogni energetici sempre più elevati, ai costi e la necessità di dati di elevata qualità, non così facili da reperire online. Nel frattempo però OpenAI , la non-profit destinata a diventare for-profit, oggi è una startup che vale 157 miliardi di dollari, seguita da xAI di Elon Musk (50 miliardi) e Anthropic (che ha incassato 8 miliardi da Amazon e 2 da Google). Amazon, Meta, Microsoft e Alphabet-Google l'anno scorso hanno investito 200 miliardi di dollari nell'AI generativa, e nel 2025 potrebbero arrivare a 300 miliardi . Questo per dare l'idea di un mondo che sta correndo a tutta velocità, mentre in Italia c'è ancora chi fatica a investire nella digitalizzazione di base. Eppure i dati parlano chiaro: chi ha investito in questo settore ha posto le premesse per una crescita solida e duratura nel tempo. Lo sanno bene gli esperti di Digital Innovation, che ormai hanno 51 Osservatori attivi , con 13 mila partecipanti (in presenza e online), 220 imprese che hanno sottoscritto accordi di partnership e sponsorship, 166 persone attive tra ricercatori e staff, oltre al personale accademico. Un piccolo esercito pacifico, proiettato verso il futuro. Tanti i numeri indicativi presenti nelle infografiche, che cercano di riassumere il lavoro portato avanti nel 2024, tra incontri operativi, confronti, convegni. Continuando a ragione sull'intelligenza artificiale (non solo generativa), scopriamo che il 61% delle grandi aziende italiane dichiara di avere all'attivo progetti di AI , almeno a livello sperimentale, mentre scendiamo al 18% se si parla di PMI. È cresciuta del 20% la spesa delle aziende italiane per la gestione e l'analisi dei dati , toccando la cifra di 3,4 miliardi di euro. D'altra parte questa è una sfida cruciale: sarà sempre più importante «costruire una propria strategia di creazione di valore basata sull'utilizzo diffuso e consapevole dei dati» . Nel 46% delle aziende italiane esistono esperti in Data Management e il 36% ha un team dedicato al Data Science . Analisi descrittive dei dati vengono portate avanti anche nelle PMI nel 79% dei casi (numero in grande in crescita). Nelle infografiche trovate numeri e indicazioni sul 5G e il Cloud, la tecnologia Blockchain e la Cybersecurity, l'Internet of Things e la Space Economy, il Fintech e lo Smart Agrifood, l'Out of Home e l'Omnichannel Customer Experience... Per chi, come noi, lavora con le PMI, risulta interessante scoprire che il 65% investe massicciamente nel digitale , anche se molte aziende lamentano la mancanza di competenze adeguate nel proprio organigramma e quindi si rivolge a realtà esterne. In compenso il 70% propone attività formative ai propri dipendenti, anche se il 40% lamenta la mancanza di tempo per farlo, e il 33% una struttura organizzativa non adeguata. Negli ultimi due anni si parla di “formazione generica” nel 73% dei casi e di formazione legata alla digitalizzazione per il 61% (c'è anche un 39% per la transizione green). Infine, un accenno al mondo delle startup hi-tech , a cui appartiene anche UniSolutions: «Nel 2024 gli investimenti totali in Italia registrano una buona ripresa, pur risultando ancora ben al di sotto del consuntivo record del 2022. Affinché le startup e le scaleup italiane possano crescere in modo più consistente, è essenziale un impegno coordinato, che non può prescindere da condizioni di contorno favorevoli per spingere l'innovazione» . Noi ci siamo!

9 gennaio 2025
Quante cose può fare ChatGPT per un'azienda ? Tante, tantissime. Può rispondere a domande anche molto specifiche ed elaborare strategie aziendali; può fornire informazioni, dati, analisi di mercato e scrivere documenti e report , ma anche aiutarci nella gestione delle risorse interne, per migliorare la produttività; è utile per la formazione , la risoluzione creativa dei problemi, l'elaborazione di grafici e immagini pubblicitarie. Tutto dipende dalla capacità di interagire nel modo giusto, allenandosi a fornire il “prompt” ideale , una richiesta-comando che funzioni come una mappa per guidare l'intelligenza artificiale nella sua risposta, cercando di essere chiari e concisi, senza però risultare troppo generici (i dettagli sono importanti!). Fondamentali sono il “gancio”, cioè l'inizio della richiesta, e il tono scelto. Questo vale soprattutto per ChatGPT-4 , che ha portato ancora più in là le capacità della tecnologia elaborata da OpenAI. Ad agosto 2024, la quarta versione ha superato i 200 milioni di utenti attivi nel mondo. In Italia, già nel gennaio 2023 si parlava di 1,3 milioni di utenti, con 9,3 milioni di interazioni e una crescita del 330% rispetto al trimestre precedente. ChatGPT-4 rappresenta un notevole salto di qualità rispetto alla versione precedente. Quali sono le principali differenze? 1. Comprensione avanzata : La quarta versione riesce a comprendere il contesto delle conversazioni in modo più preciso e quindi è anche più efficace nel rispondere a domande complesse e nel fornire risposte contestualizzate. 2. Linguaggio più naturale : Ha un linguaggio più fluido e simile a quello umano. Le risposte risultano meno "meccaniche", con una maggiore capacità di variare il tono in base alla richiesta dell’utente. 3. Elaborazione dati multimodali : Una delle novità più rilevanti è la capacità di elaborare non solo testi ma anche immagini, che possono essere inviate come input per ricevere analisi o descrizioni dettagliate. 4. Maggiore accuratezza : GPT-4 è stato addestrato con un set di dati più ampio e aggiornato, il che lo rende meno incline a errori rispetto a GPT-3, soprattutto in ambiti complessi e tecnici. 5. Sicurezza ed etica : GPT-4 è stato progettato per essere più sicuro, con una riduzione del rischio di generare contenuti inappropriati o dannosi. Quali sono i settori chiave in cui questa tecnologia può fare la differenza nell'utilizzo aziendale? 1. Servizio clienti : Con risposte più rapide e precise, ChatGPT-4 può gestire chatbot aziendali, migliorando l’esperienza del cliente e riducendo i tempi di risposta. 2. Creazione di contenuti : è utile alla generazione di testi per blog, post sui social media, email e altri materiali promozionali. 3. Formazione interna : Le aziende possono utilizzare GPT-4 come strumento educativo, per creare programmi di formazione personalizzati per i dipendenti. 4. Automazione dei processi : Aiuta le imprese a risparmiare tempo e risorse, attraverso l'analisi di dati e la generazione di report, aumentando l’efficienza. 5. Ricerca e sviluppo : La sua capacità di analizzare grandi quantità di dati può essere impiegata per identificare trend, sviluppare prodotti innovativi e migliorare le strategie aziendali. Da sottolineare, tra le altre cose, la capacità di processare foto, diagrammi e grafici, ma anche la possibilità di produrre traduzioni avanzate, comprendendo sfumature linguistiche e culturali, e di adattarsi al tono e al linguaggio di chi lo utilizza, fornendo risposte altamente personalizzate. Il prossimo passo? Sebbene OpenAI non abbia ancora rilasciato informazioni ufficiali sulla prossima versione, si prevede che ChatGPT-5 possa essere introdotto tra il 2025 e il 2026, continuando il trend di innovazione. Ecco alcune delle novità ipotizzate: 1. Elaborazione completamente multimodale : ChatGPT-5 potrebbe integrare ulteriori modalità di input, come l’analisi audio e video, permettendo di processare conversazioni vocali e analizzare contenuti video. 2. Memoria a lungo termine : Una delle funzionalità attese è la capacità di mantenere una memoria contestuale persistente su interazioni prolungate, rendendolo ancora più efficace in applicazioni personalizzate. 3. Apprendimento continuo : GPT-5 potrebbe essere in grado di apprendere in tempo reale dalle interazioni, adattandosi continuamente alle esigenze dell’utente senza richiedere aggiornamenti manuali. 4. Miglioramenti nell’etica e nell’equità : Si prevede che GPT-5 sarà progettato con modelli ancora più avanzati per evitare bias e garantire un utilizzo etico. 5. Efficienza energetica : Andando incontro alla crescente attenzione alla sostenibilità, GPT-5 potrebbe essere più efficiente dal punto di vista energetico, riducendo il consumo di risorse nei data center.

13 dicembre 2024
Italia, terra di poeti, navigatori e... supercomputer . Dopo Leonardo , nato a Bologna nel novembre del 2022, grazie a un investimento di 240 milioni di euro, sta per approdare in terra emiliana un altro supercalcolatore, pensato per l' intelligenza artificiale . Si tratta di un investimento da 430 milioni, che trasformerà il Tecnopolo di Bologna in una delle prime AI Factory europee. Se da una parte siamo rimasti indietro nello sviluppo dell'intelligenza artificiale generativa, dall'altra siamo più avanti di tutti sul fronte dei supercomputer e quindi della possibilità di sfruttare al meglio le potenzialità dell'AI. Ancora una volta – come dovrebbe accadere sempre – si incontrano istituzioni, aziende e università, pubblica amministrazione e mondo della ricerca, Pmi e startup, dentro un progetto che l'Europa ha premiato insieme ad altre sei factory, che verranno ospitate in Germania, Finlandia, Svezia, Spagna, Grecia e Lussemburgo. L'IT4LIA AI Factory è finanziato dall'European High Performance Computing Joint Undertaking e sarà gestito dal consorzio interuniversitario Cineca. Quali saranno i frutti di questo progetto? Lo sviluppo di soluzioni AI . Che in prima battuta guarderanno soprattutto all' agroalimentare e al manifatturiero , ma anche alla cybersicurezza e allo studio del clima e della terra (per prevenire i rischi legati agli eventi climatici estremi), unendo obiettivi pratici, legati all'ammodernamento di alcuni settori produttivi, e finalità scientifiche e conoscitive. Si parla di big data, ma anche di calcolo quantistico , l'ultima frontiera, quella che potrebbe portare a una rivoluzione quasi inimmaginabile nel nostro modo di vivere, lavorare, produrre. Ma ci saranno anche obiettivi intermedi, legati all'ecosistema economico italiano, visto che le piccole e medie imprese saranno le prime a beneficiare di queste soluzioni innovative, in collaborazione con varie startup. Come ha detto Francesco Ubertini, presidente di Cineca: «Questo è un successo di squadra, una enorme opportunità per il nostro Paese, che si conferma al centro dello sviluppo tecnologico europeo. Siamo orgogliosi di poter mettere a disposizione di tutti un’infrastruttura all’avanguardia che favorirà la crescita di startup, Pmi e interi settori industriali. È una vittoria per l’innovazione italiana e per il futuro dell’intelligenza artificiale in Europa» . Si parla ormai di un miliardo di euro di investimento complessivo del nostro paese per lo sviluppo di risorse di calcolo all'avanguardia e le relative infrastrutture (i supercomputer richiedono una logistica di vaste dimensioni). Contribuiscono all'impresa varie realtà, dal Ministero dell’Università e della Ricerca al consorzio Cineca (in collaborazione con Austria e Slovenia); dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN); dalla Regione Emilia-Romagna all’Agenzia ItaliaMeteo; dall’Istituto italiano di Intelligenza Artificiale per l’Industria (AI4I) alla Fondazione Bruno Kessler (FBK). Importante anche il ruolo della Fondazione ICSC – Centro Nazionale di Ricerca in HPC Big data and Quantum Computing. Il futuro passa attraverso l'innovazione digitale e l'intelligenza artificiale , con le sue infinite applicazioni possibili. Bisogna solo decidere se subire il processo in atto (le Pmi italiane arrivano spesso in ritardo) o se viverlo attivamente, creativamente, migliorando i processi produttivi e, perché no, anche la qualità della vita.
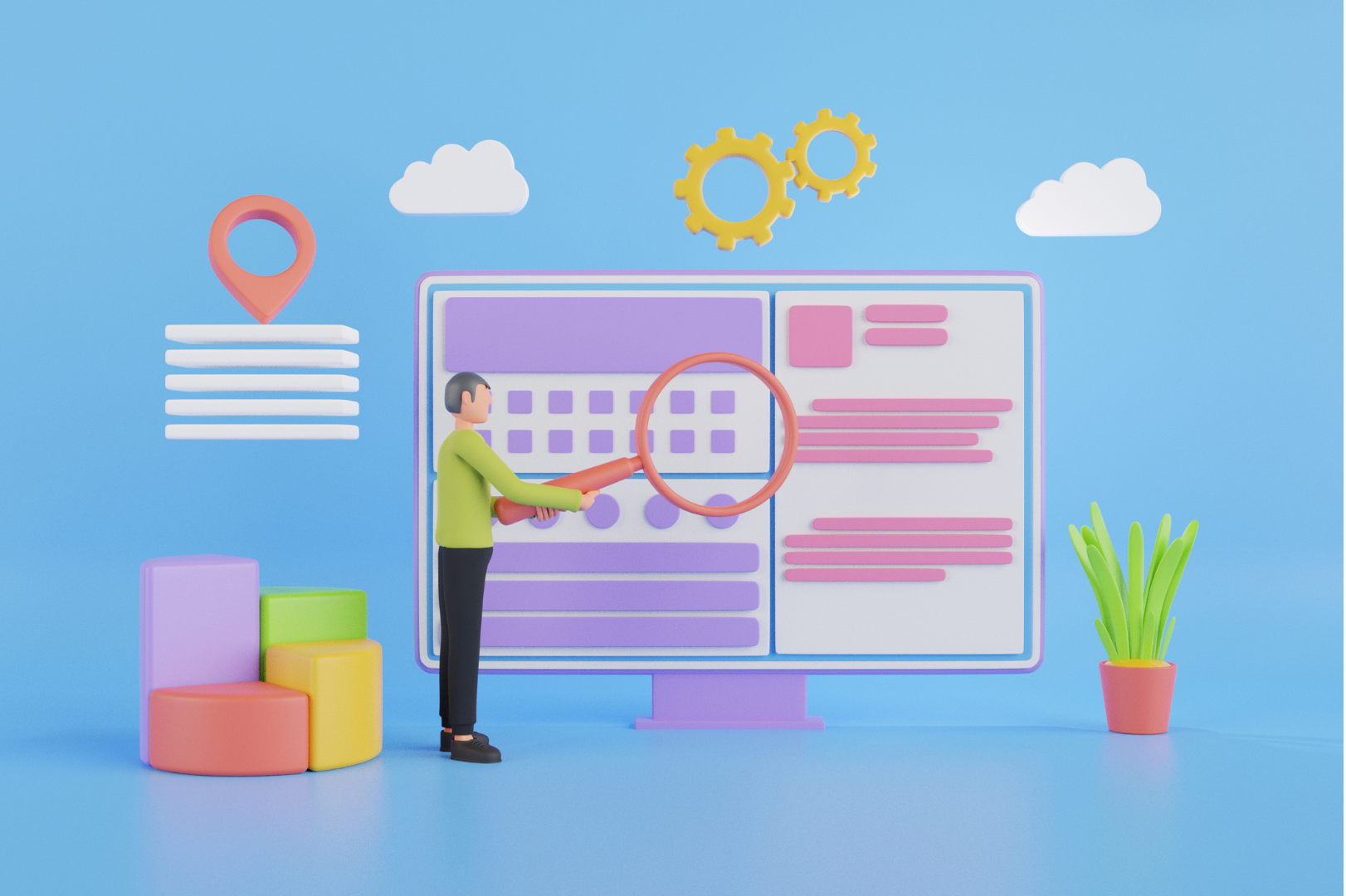
4 dicembre 2024
Si scrive Seo , Search Engine Optimization, ottimizzazione per i motori di ricerca. Ma ormai si legge Search Everywhere Otpimization , perché i canali si moltiplicano, i social sono sempre più utilizzati anche per la ricerca di informazioni e prodotti, e la diffusione di ChatGPT sta rivoluzionando ulteriormente le statistiche. Lo dice Neil Patel , uno dei massimi esperti mondiali di marketing. Lo conferma, giorno dopo giorno, chi lavora in questo campo. Un settore, peraltro, che l'intelligenza artificiale sta scuotendo dalle fondamenta, visto che l'AI sarà sempre più indispensabile per riuscire a gestire i vari canali, monitorare i dati di ricerca, creare contenuti utili a farsi trovare dal cliente. Non per niente, nel 2024, il Marketing Jobs Outlook di Linkedin ha fatto registrare un aumento del 76% delle offerte di lavoro nel settore. Ma cresce anche la richiesta di competenze AI. Il 72% degli esperti di marketing confessa di sentirsi sopraffatto dalla velocità dei cambiamenti in atto. Anche per questo diventeranno sempre più importanti le applicazioni nate dall'intelligenza artificiale e i software in grado di implementare le capacità dell'AI generativa. Per ora, secondo Neil Patel, la maggior parte dei professionisti utilizza l'AI per creare campagne o personalizzarle . O anche per elaborare testi e immagini. Ma qui bisogna stare attenti al tipo di lavoro portato avanti, soprattutto se si tratta di dare autorevolezza a un brand, perché in questo caso risulta fondamentale produrre contenuti inediti , caratterizzati dalla qualità della scrittura e delle informazioni fornite, oltre che dall'empatia, la trasparenza, l'efficacia comunicativa. Altra cosa, aggiungiamo noi, è la generazione di contenuti per rendere più efficiente la presenza dell'azienda su vari canali , anzi, nel luogo e nel momento in cui la stanno cercando (in cui vengono fatte ricerche su un determinato prodotto o servizio). Google rimane il punto di riferimento per le ricerche online, e per chi elabora strategie di marketing. Ma i numeri dicono che ormai un utente su quattro utilizza i social per cercare informazioni sui prodotti. Con percentuali davvero importanti se si parla degli utenti della Gen Z, che usano Instagram come motore di ricerca nel 67% dei casi. Se poi ampliamo lo sguardo, scopriamo che metà dei consumatori ormai cominciano le loro ricerche da Amazon. Un discorso a parte andrebbe fatto per Tik Tok . I video brevi hanno conosciuto una diffusione straordinaria e quindi sono molto utili per attrarre nuove persone. Ma i dati dicono che il numero delle conversioni aumenta con i “long form”, i video più lunghi, i testi che garantiscono informazioni di qualità e competenze professionali. Secondo Patel «non c'è un declino nel traffico Google, che continua a essere il canale principale al mondo, con 8,5 miliardi di ricerche al giorno, ma non è più l’unico punto di attenzione quando si tratta di ottimizzare i contenuti. Considerare le tante piattaforme utilizzate dagli utenti per le loro ricerche è uno sforzo, ma ha diversi vantaggi: permette di intercettare nuovi potenziali clienti, audience differenti, aumentando i touchpoint » . Questo non significa che va abbandonata la Seo, ma che va trasformata, arricchita, cercando di lavorare su vari canali (con strumenti adeguati) per stare al passo con le abitudini degli utenti, che cambiano continuamente e diventano sempre più complesse. Ad esempio, il “clic-to-buy” del social commerce ormai coinvolge 460 milioni di utenti al mese. Risulta fondamentale analizzare efficacemente le campagne avviate, automatizzando certe attività attraverso la tecnologia, per poi decidere in quale direzione investire (o facendolo decidere all'AI). Cambiano le abitudini degli utenti, cambia il marketing, ma la tecnologia ci aiuterà a governare la complessità.
© 2025
Copyright © Uni Solutions - P.IVA 13432990961 | All rights reserved


